Si può giocare a ping pong con la Corea del Nord? O forse solo a calcio? Speriamo di no.
Gli accordi di Pechino del 1972 con i quali la Cina – sovversiva agli occhi sovietici ma in realtà fautrice di un “proprio” comunismo – venne formalmente e sostanzialmente traslata nel blocco occidentale in un sistema triangolare (in cui gli altri due poli erano USA e Giappone) trovano un retroscena quasi romanzesco nella famigerata “diplomazia del ping pong”.
Giusto per alleggerire e sforzarsi di colorare la plombe diplomatica kissingeriana. Al termine di un torneo di ping pong che vedeva impegnate sul campo la squadra cinese e quella statunitense, Glenn Cowan, dimenticato sbadatamente dalla sua squadra, venne accompagnato gentilmente dalla delegazione cinese e, durante il tragitto, iniziarono a colloquiare. La simpatia fu talmente forte che la delegazione americana venne invitata in suolo cinese, per un nuovo match di ping pong, è chiaro. Fatto sta che Stati Uniti e Cina, andando oltre i formali accordi di Pechino, in questi 41 anni non si sono limitati a partite di ping pong. Visti i risultati sorprendenti, si potrebbe pensare ad una partita con la Corea del Nord? Gli sportivi non lo escluderebbero ma la storia ha un corso diverso. La Corea del Nord non è la Cina, e il 2013 non è il 1972.
La divisione della Corea rappresenta l’esempio più remoto, per di più ancora tangibile, della “politica delle sfere d’influenza” , marchio a fuoco degli albori della guerra fredda. Essa è in modo lampante anche il primo esempio dell’uso spregiudicato dell’imperialismo giustificato da dettami ideologico-difensivi da parte delle grandi potenze (gli Stati Uniti e l’annaspata Unione Sovietica, poi la Cina) e delle Nazioni Unite, chiamate a legittimare la loro presenza nella penisola. La spaccatura del 1945 tra un Nord filo-sovietico e un Sud filo-americano è stata la più severa tra le separazioni di Stati della storia contemporanea.
Probabilmente il destino della Corea poteva dirsi segnato: se nel 1943, troncandola dal Giappone, “avrebbe guadagnato indipendenza a tempo dovuto”, in una torrida notte di agosto del 1945 il suo futuro venne marchiato con un tratto di matita su di una cartina della National Geographic Society. Il celebre trentottesimo parallelo, appunto. Potremmo dire che la Corea nasce divisa? Sicuramente fu fatta nascere in chiave anti-giapponese (o almeno post-giapponese). C’è chi la definisce la Germania postbellica del Pacifico: da un lato il nord appoggiato dalla Cina e dall’altro il sud filo-USA; ma mentre in Europa ci è voluto il crollo del comunismo (sovietico) per ricompattare la nazione tedesca, qui è il bastone cinese che dovrebbe crollare. Siamo sicuri, però, che venuto meno il supporto cinese (ideologico e non) i due lembi della penisola tendano naturalmente a ricucirsi? In realtà, anche se la Corea non fosse nata come due entità politiche separate, la divisione della penisola è ormai irreversibile: sono abissali le differenze politiche ed economiche, riflesso di ideologie opposte, a maggior ragione se si considera che alle spalle le due Coree vedono la presenza di due grandi potenze. Il Sud ospita una popolazione cristiana tra le più ferventi d’Asia, mentre il Nord ha sviluppato un culto comunista della personalità che è stato – e rimane – più fanatico perfino di quelli di Mao o Stalin; alle soglie del XXI secolo il Nord è stremato dalle carestie e dal declino economico mentre il Sud è la dodicesima potenza economica del mondo. Né cinesi e statunitensi, inoltre, hanno interesse a invadere il lembo avversario della penisola, uniformandola alla rispettiva fede: sono consci della incredibile destabilizzazione che si verificherebbe.
Da un punto di vista geo-strategico, un ipotetico crollo cinese determinerebbe un vuoto nel gioco di contrappeso con gli Stati Uniti; si è nel campo delle pure congetture, è da intendersi, dato che un tale scenario non pare prospettarsi nel prossimo futuro. Ma un passo indietro cinese potrebbe profilarsi anche solo con un mancato appoggio – o addirittura una condanna – alle mosse nordcoreane: cosa che sorprendentemente è avvenuta. Quello che ha più sconcertato lo scenario internazionale, in seno agli ultimi avvenimenti nel sud-est asiatico, è stata quell’apparente rottura del cordone tra Pechino e Pyongyang. Senza dubbio la decisione nordcoreana di effettuare manovre nucleari “in maniera perfetta e sicura” è stata architettata approfittando del tumulto transitivo nel Pacifico, (cambio di leadership politica in Giappone, Cina e Corea del Sud, oltre che i non trascurabili festeggiamenti per il capodanno lunare) per poter agire senza avere il fiato sul collo. Ma la risposta cinese si è avuta eccome, ed è stata oltre che una ferrea condanna, la redazione congiunta con gli statunitensi di una bozza di risoluzione punitiva, adottata poi all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite lo scorso 7 marzo.
 Solitamente queste prove di forza a carattere militare vengono interpretate come una dimostrazione di potere da parte del leader in carica – prima Kim Jong-il, ora Kim Jong-un – e come un modo di ricompattare le Forze armate e una popolazione le cui condizioni di vita rimangono proibitive dietro alla bandiera del nazionalismo. Stante l’isolamento quasi totale del regime nordcoreano, l’unico partner commerciale e politico di rilievo è la Repubblica Popolare Cinese. Ma gli inviti – non privi di toni ultimativi – alla moderazione di Pechino non sono stati ascoltati, e il suo sostegno alla risoluzione Onu di condanna per il test missilistico è stato clamorosamente ripagato con un test nucleare. Pyongyang parla di “diritto di difesa” non già da Seoul ma da Washington, e di star agendo “per proteggere la sicurezza nazionale e la sovranità dalla feroce ostilità degli Stati Uniti”. Kim Jong-un sfida il mondo a partire dall’alleato cinese: è un chiaro segnale che la Corea del Nord non vuole essere considerata alla mercé della Cina.
Solitamente queste prove di forza a carattere militare vengono interpretate come una dimostrazione di potere da parte del leader in carica – prima Kim Jong-il, ora Kim Jong-un – e come un modo di ricompattare le Forze armate e una popolazione le cui condizioni di vita rimangono proibitive dietro alla bandiera del nazionalismo. Stante l’isolamento quasi totale del regime nordcoreano, l’unico partner commerciale e politico di rilievo è la Repubblica Popolare Cinese. Ma gli inviti – non privi di toni ultimativi – alla moderazione di Pechino non sono stati ascoltati, e il suo sostegno alla risoluzione Onu di condanna per il test missilistico è stato clamorosamente ripagato con un test nucleare. Pyongyang parla di “diritto di difesa” non già da Seoul ma da Washington, e di star agendo “per proteggere la sicurezza nazionale e la sovranità dalla feroce ostilità degli Stati Uniti”. Kim Jong-un sfida il mondo a partire dall’alleato cinese: è un chiaro segnale che la Corea del Nord non vuole essere considerata alla mercé della Cina.
Se con Xi Jinping, Presidente della Repubblica popolare cinese dallo scorso 14 marzo, si può pensare a qualche moderata sterzata, soprattutto per esigenze di visibilità internazionale oltre che strategicamente necessarie per la Cina (che continuerà la sua politica assertiva e aggressiva nei confronti del Giappone per le note rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese Orientale e Meridionale riguardanti le isole Daoyu e Senkaku e ovviamente penserà a irrobustire ancor più il legame economico con Tokyo e Washington) la linea di politica estera di Pyongyang non pare essere cambiata da quando al potere è salito Kim Jong-un: chiodo fisso delle relazioni internazionali del Paese è la strategia della minaccia, declinata in due forme: la minaccia nucleare-missilistica e la minaccia umanitaria. La minaccia nucleare, risalente alla fine degli anni Ottanta è basata sulla messa in opera di un programma missilistico-nucleare diretto contro Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. Da Kim Jong-il in avanti, detenere l’arma nucleare, e soprattutto poter portare un attacco missilistico nucleare, significa per il regime entrare a far parte di un club esclusivo che gode ancora oggi di maggior rispetto e considerazione tra la Comunità degli Stati. La minaccia umanitaria riguarda invece l’eventualità che un collasso interno del regime spinga flussi ingentissimi di persone a emigrare verso i confini cinesi, sudcoreani e russi. Proprio questa seconda minaccia tiene in pugno Pechino. Nonostante il calibro economico che Pechino ha in Corea del Nord (primo partner commerciale del regime con un interscambio stimato in oltre 5 miliardi di dollari ed una dipendenza nordcoreana superiore al 70%), il rischio di una implosione interna del regime, con conseguente destabilizzazione dei confini, rendono la Cina propensa ad una difesa dello status quo.
Ma è possibile che del trascorso della Corea bisogna parlare solo in termini internazionali? Non è da intendersi una faccenda peninsulare o, al massimo, sub-continentale? Sessant’anni di confronto militare hanno reso ogni ipotesi di conflitto armato in Corea un gioco a somma zero, senza vincitori né vinti. Del resto, la causa nordcoreana andrebbe scissa tra un miraggio di dominio sulla parte meridionale, uniformando la penisola, ma passandoci attraverso una cacciata degli Stati Uniti dalla “loro” penisola. «Tutti i coreani devono prendere parte alla grande e giusta guerra per la riunificazione della patria e cacciare gli Stati Uniti dal suolo coreano», cita un comunicato stampa di Pyongyang dello scorso 18 marzo. In linea di ciò la stracciata dell’armistizio del 1953 è schiarita in linea con questa congettura: l’armistizio infatti poneva un mero stato di tregua tra due Coree indipendenti. Pertanto, dichiararlo nullo equivale a non dover riconoscere più la dualità delle due Coree, e ovviamente a riprender le armi in pugno. Ma in che direzione va la guerra? L’una contro l’altra o, patriotticamente, assieme? Ora che la Cina pare togliere il suo bastone d’appoggio, dovrebbero far lo stesso gli Stati Uniti, in modo che Seoul non si trovi accerchiata da due fuochi? Ma Seoul intende percorrere il tragitto teorizzato da Kim Jong-un?
Pare difficile per gli Stati Uniti pensare di schiodarsi dalla penisola (e non solo per motivi nostalgici) e dormire sonni tranquilli: «I satelliti e i missili a lunga gittata che noi continueremo a lanciare e i test nucleari di alto livello che faremo sono rivolti al nostro nemico giurato, gli Stati Uniti» è la ricorrente affermazione della Commissione di difesa nazionale nordcoreana. Non c’è da meravigliarsi di questa scelta, è un copione già scritto che è stato più volte reiterato dall’ormai deceduto leader Kim Jong-il, nel 2006 e poi nel 2009. I muscoli di Washington nell’esercitare da sola il controllo egemonico mondiale stanno cedendo; Pechino invece capisce che una politica di isolamento non può certo tutelare i propri interessi.
Nell’ estate del 2002, gli Stati Uniti giunsero alla conclusione che la Corea del Nord stava conducendo un programma segreto di riarmo nucleare in violazione degli obblighi internazionali, e le tensioni si aggravarono quando all’ inizio del 2003 la Corea del Nord fu il primo Paese a uscire dal Trattato di non proliferazione nucleare. Nonostante un incorniciato incontro tra il presidente sudcoreano Kim Dae-jung e il leader nordcoreano Kim Jong-il, e della visita a Pyongyang del Segretario di Stato americano Madeleine Albright, gli Stati Uniti, senza agire troppo sottobanco, hanno continuato negli anni a infoltire le truppe di schieramento sulla linea di trincea della penisola. Avevano capito – e ora più che mai – che i Kim facevano sul serio. Se durante la guerra fredda Pyongyang rappresentava la roccaforte del comunismo, negli anni 2000 assume la conformazione dei mali da combattere, comparendo come membro ad honorem dell’ “Asse del Male” accanto a Iraq e Iran, nel discorso della Casa Bianca sullo stato dell’Unione nel 2002. Alcuni azzardarono che quella nomina permetteva a uno Stato canaglia “di serie B” di ottenere il privilegio di essere iscritto nell’ agenda della presidenza degli Stati Uniti. Non seguirono ringraziamenti. C’è chi, di posizione nordcoreana indubbiamente più vantaggiosa, ricorda l’episodio in cui stupì il mondo battendo la nazionale italiana di calcio ed entrò nei quarti di finale dei mondiali del 1966. Gli abitanti di Middlesborough, la città inglese che ospitò l’incontro, divennero subito tifosi della Corea del Nord, la cui tattica di gioco consisteva nel correre all’ impazzata per tutto l’incontro; uno stile che in seguito fu ribattezzato “calcio totale”.
In politichese internazionale si chiama “massive retaliation” ed è quello che la comunità internazionale, oggi, spera che non avvenga. Pensare che lo stesso taglio della linea rossa che c’era stato già nel 2010 non abbia portato poi ad ulteriori manovre d’azzardo, vale solo per rincuorarsi mettendosi uno scudo sugli occhi. Non è lavoro da palla di vetro, ma si tratta di leggere tra le righe dell’ incitato spot nordcoreano: nuclear pre-emptive war. Può esistere una guerra difensiva quando ci si destreggia con armi nucleari?

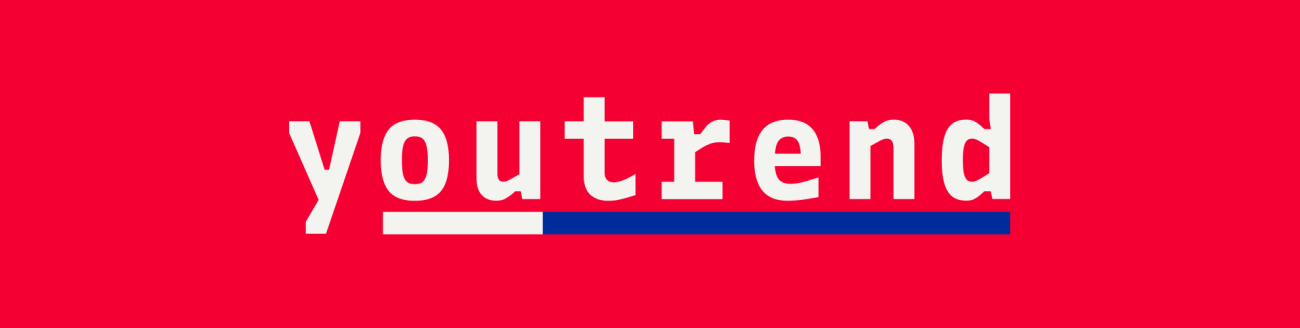
Commenta