Negli Stati Uniti li chiamano “horse race polls”, i sondaggi che trasformano le elezioni in una corsa di cavalli dove conta solo chi è avanti e chi è indietro. Dopo l’inaspettata vittoria di Donald Trump le previsioni elettorali non sono state più viste allo stesso modo, per evidenti motivi. In molti si sono interrogati sulle ragioni che hanno portato tutti i principali istituti di ricerca a mancare l’esito del voto. Si è indagato meno sull’effetto che i sondaggi hanno avuto sugli elettori.
Proprio su questo aspetto si è concentrato uno studio condotto da Sean Westwood del Darthmouth College, Yphtach Lelkes dell’Università della Pennsylvania e Solomon Messing del Pew Research Center. È stato lo stesso Messing a esporre le conclusioni della ricerca in un articolo pubblicato di recente.
Le proiezioni elettorali non sono tutte uguali: se in Italia siamo abituati a confrontarci con percentuali di voto, oltreoceano ha preso piede negli ultimi anni un’impostazione diversa. Si tratta di una stima che non solo suggerisce la distanza tra i candidati in un dato momento ma ne valuta le probabilità di vittoria. Per intenderci, un conto è dire che una coalizione è invantaggio con il 35% dei voti, un altro è dire che ha il 60% delle possibilità di vincere le elezioni.
La differenza è sottile ma sostanziale, visto che secondo la ricerca questo tipo di proiezione darebbe agli elettori un’impressione più netta del vantaggio di un candidato, influenzando perfino la partecipazione al voto. I dati sono gli stessi, cambia il modo in cui vengono presentati e, di conseguenza, come vengono percepiti dall’opinione pubblica.
Lo studio prende le mosse dalla constatazione che nei media americani le previsioni di questo genere sono sempre più diffuse. Nel corso delle elezioni presidenziali sono state una costante, con una media di 16 menzioni giornaliere nei principali canali di informazione, in particolare tra l’audience più liberal. La maggioranza dei sondaggisti erano concordi nel dare a Hillary Clinton una probabilità di vittoria che andava dal 70% al 99%.
Le previsioni probabilistiche erano però salite alla ribalta già in precedenza. Almeno da quando, nel 2008, “azzeccarono” la corsa al Senato in quasi tutti gli Stati – nonché la vittoria di Obama alle presidenziali. Su Google News il numero di articoli che vi fanno riferimento era di 907 nel 2008, 3.860 nel 2012, 15.500 nel 2016.
Per indagare in che modo influenzino l’opinione pubblica, il team di ricercatori ha presentato a un campione di 4.151 persone un’ipotetica corsa al Senato degli Stati Uniti. A tutti i partecipanti sono stati sottoposti gli stessi numeri, ma con tre modalità differenti: sotto forma di percentuale di voti (es. il candidato A dovrebbe prendere il 55% dei voti), con l’equivalente probabilità di vittoria (es. il candidato A ha l’87% delle possibilità di vincere) oppure con entrambe le proiezioni. Successivamente è stato chiesto loro di giudicare quanto fossero certi che il candidato A avrebbe vinto o perso, la percentuale che si aspettavano per il candidato A e le sue probabilità di vittoria. Risultato: coloro che avevano preso in considerazione le probabilità risultavano più ottimisti nella valutazione del candidato in vantaggio e nelle sue possibilità di vittoria finale.
L’esperimento suggerisce pertanto che la diffusione nei media delle probabilità rafforza la percezione di un risultato definito, molto più di quanto avviene con le classiche proiezioni percentuali. Di per sé il modo in cui le persone interpretano i sondaggi potrebbe sembrare irrilevante, se non fosse che può influenzarne il comportamento elettorale con il famoso effetto bandwagon (di cui abbiamo parlato non molto tempo fa). Da questo punto di vista sono diverse le ricerche secondo cui se un’elezione appare incerta, il tasso di partecipazione si fa più elevato. Quello che i ricercatori si sono chiesti è se fosse valido anche l’opposto: un’elezione che sembra già decisa porta a una minore partecipazione?
Per rispondere a questa domanda hanno condotto un ulteriore test, che ha riguardato stavolta 1.171 persone, organizzato come un piccolo gioco economico. Gli intervistati potevano infatti decidere di versare una piccola quota per “votare” la propria squadra: se avesse vinto avrebbero guadagnato dei soldi e ne avrebbero persi in caso contrario. Al tempo stesso però potevano anche scegliere di non votare, beneficiando comunque di un guadagno qualora avesse vinto la “squadra” da loro scelta. L’idea era quella di simulare le motivazioni che spingono i potenziali elettori a decidere di andare a votare nel mondo reale. Ai volontari sono state poi riferite le probabilità di vittoria dei loro candidati e le loro percentuali di voto, mentre i numeri definitivi sono stati selezionati in modo casuale.
Il test confermerebbe che il modo in cui gli elettori interpretano i sondaggi ne influenza anche le scelte. Nello specifico, a fronte di alte probabilità di vittoria, i partecipanti hanno deciso di non spendere le risorse necessarie per esprimere un voto nella finta elezione. È da notare che questa decisione ha riguardato in modo sproporzionato i sostenitori di uno solo dei candidati fittizi: quello dato per vincente. La visione delle percentuali di voto invece non ha avuto effetti rilevanti sulla partecipazione.
Le probabilità non portano a sovrastimare le possibilità di vittoria di un candidato (come mostra il secondo grafico), ma il fatto di conoscerne le chance di successo indurrebbe a considerare più certo l’esito finale, con un effetto potenzialmente significativo sul numero di votanti. In altre parole, se la sensazione è che non ci sia reale competizione allora non vale la pena spendere il proprio voto.
Va sottolineato che la tesi si regge naturalmente su un modello di analisi, non sulla realtà. Le variabili che influiscono sulla scelta di recarsi o meno alle urne sono molte e complesse e si può discutere sul fatto che il versamento di una quota di denaro possa rappresentarle adeguatamente. Ciononostante, ricerche simili che misurino le preferenze degli elettori in un’elezione reale non esistono e il lavoro presentato da Solomon Messing apre prospettive inedite sul ruolo dei sondaggi elettorali (quantomeno negli Stati Uniti): non solo collettori passivi di opinioni di voto ma fattore che contribuisce almeno in parte anche a determinarle, confondendo e/o smobilitando l’elettorato.

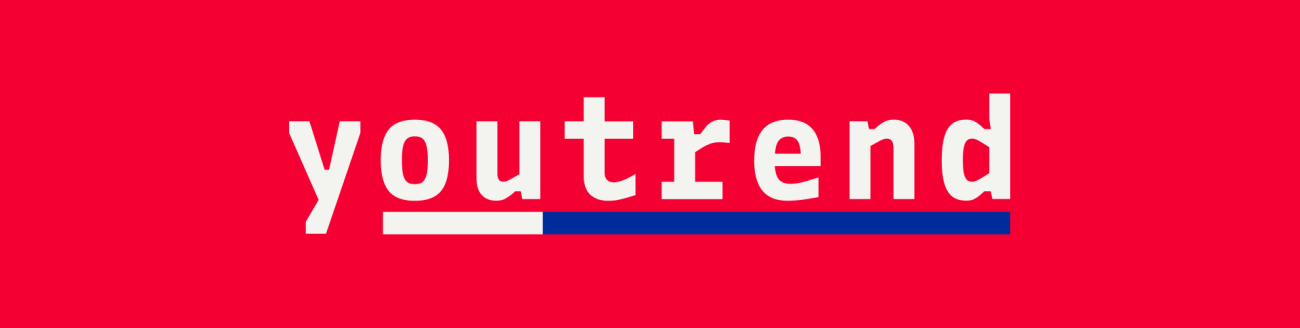
Commenta