Sul finire del 2017, durante l’estenuante avvicinamento alla fine della legislatura, era difficile capire quali fossero le prospettive e gli obiettivi del Partito Democratico. Dodici mesi di Governo Gentiloni non erano riusciti a ricucire le spaccature sorte dal referendum costituzionale. La netta vittoria di Matteo Renzi contro Orlando ed Emiliano nel congresso di aprile non era stata sufficiente a restituirgli la fiducia del passato.
La campagna elettorale
Insomma, un PD che fino a ottobre 2017 era riuscito a contendere la palma di primo partito al Movimento 5 Stelle iniziava il 2018 in ordine sparso, fra le tensioni per la composizione delle liste e quelle per l’occasione mancata dello ius soli. Il consenso all’inizio di quest’anno, quindi, si aggirava intorno al 23%, senza grandi oscillazioni registrate durante la campagna elettorale.
Una campagna elettorale impostata da incumbent e incentrata su due filoni principali e complementari (illustrata nel dettaglio nel libro “Una Nuova Italia”). Da un lato la rivendicazione dei risultati del cosiddetto “Governo dei mille giorni”, espressione altisonante e un po’ fiabesca per indicare il Governo Renzi. Dall’altro la definizione di un’identità ben precisa come partito del progresso (e della scienza), dell’Europa, del lavoro, dell’ambiente: molti temi, non tutti popolari e difficilmente in grado di mobilitare gli elettori senza essere collegate a proposte di policy specifiche e di impatto.
Le ambizioni
Una parte delle speranze del PD era concentrata poi sulla coalizione di centrosinistra varata (faticosamente) con Civica Popolare di Beatrice Lorenzin, con gli ulivisti di Insieme e, soprattutto, con +Europa di Emma Bonino. In base alla nuova legge elettorale (il Rosatellum), infatti, le liste coalizzate che ottengano fra l’1 e il 3% portano i propri voti alla coalizione nella quota proporzionale ma non eleggono candidati. In questo modo il PD sperava di accrescere il proprio gruppo parlamentare di una ventina di deputati, in cambio di alcune candidature collegi uninominali “blindati” ai principali esponenti delle varie liste, come contropartita.
Ma con l’avvicinarsi del voto si infittivano i dubbi sulle ambizioni che il PD potesse nutrire in vista delle elezioni: impossibile governare da solo o con l’insufficiente sostegno di Liberi e Uguali, poteva al massimo sperare in un accordo di grande coalizione. Nel sondaggio predittivo svolto fra i nostri utenti nei giorni precedenti al voto era proprio una maggioranza formata da PD, Forza Italia e centristi quella accreditato delle migliori chance per il governo: circa un quarto delle risposte lo davano come più probabile di qualsiasi altro scenario, davanti a un governo “del presidente” e a una maggioranza autonoma di centrodestra.
Il terremoto del 4 marzo
Il giorno dopo le elezioni, però, il Partito Democratico si ritrova di fronte al peggior risultato elettorale della sua storia. Al di là del 18,7% ottenuto a livello nazionale, già pessimo di per sé, sono i risultati locali a indicare la crisi nerissima del centrosinistra: perde la metà dei collegi (15 su 31) nelle roccaforti storiche – Toscana ed Emilia-Romagna – e gli unici altri collegi che riesce a vincere sono nel centro di Roma, Torino e Milano, mentre al Centro-Sud e nelle isole non va oltre il 15%. L’unica nota positiva è il successo di Nicola Zingaretti nelle Regionali del Lazio con il 31%; si tratta, però, di un risultato soprattutto personale, visto che alle Politiche nella stessa regione il centrosinistra è terzo per distacco, con meno del 23%.

In una conferenza stampa, Renzi colloca il partito all’opposizione, escludendo qualunque possibilità di accordo con la Lega o il Movimento 5 Stelle. Contemporaneamente, annuncia le sue dimissioni da segretario e il ridimensionamento del suo ruolo a “senatore semplice”, ma tutto ciò solo dopo le consultazioni per la formazione del governo.
Le consultazioni
Le polemiche per la scelta di Matteo Renzi sono seguite dalla nomina di Maurizio Martina a segretario “reggente”. Nel mentre, continua a essere in carica per gli affari correnti il Governo guidato da Paolo Gentiloni, nettamente il volto più popolare del PD dopo le elezioni, che viene addirittura lanciato da Renzi come candidato in caso di elezioni anticipate.
Con il passare delle settimane e il prolungarsi dello stallo, però, per Martina diventa sempre più difficile resistere alle sirene di un accordo con i 5 Stelle. Alla fine di aprile, sui social una parte della base dem contraria all’accordo rispolvera l’hashtag #senzadime, mentre Renzi approfitta di un’intervista televisiva in prima serata da Fabio Fazio per chiudere qualunque spiraglio.
L’opposizione e il congresso
Si giunge quindi all’insediamento del Governo Conte, che vede il consenso dei democratici sempre intorno al 18% del risultato elettorale. Per il PD coincide con l’inizio di una fase congressuale molto travagliata. Il primo a scendere in campo – e per alcuni mesi l’unico – è proprio Nicola Zingaretti, forte di un’alta fiducia fra gli elettori del partito e di una maggiore vicinanza con la sinistra fuori e dentro il partito. Seguiranno in autunno numerose altre candidature: Francesco Boccia, Dario Corallo, Maria Saladino, Maurizio Martina, Roberto Giachetti in ticket con Anna Ascani, Matteo Richetti, Marco Minniti e Cesare Damiano.
Di questi, l’unico in grado di competere con il front runner Zingaretti sembra Minniti. Verso la fine di novembre, però, con la scadenza per la presentazione delle candidature alle porte, tornano a farsi insistenti le voci secondo cui sarebbe possibile la nascita di un nuovo partito guidato da Matteo Renzi in vista delle elezioni europee. Questo rinfocola le polemiche interne e porta al ritiro dell’ex Ministro dell’Interno, che aveva fondato la sua candidatura sull’appoggio del segretario uscente.
Questa scelta, insieme all’uscita di scena di Damiano e Richetti, lascia il campo aperto agli outsider. Nel complesso sistema previsto dallo statuto del PD per l’elezione del nuovo segretario, infatti, i favoriti per passare dalla prima fase (il voto degli iscritti nei circoli) alla seconda (quella delle primarie aperte nei gazebo) sono probabilmente Zingaretti, Martina e Giachetti, ma non è da escludere qualche sorpresa.
Quale futuro?
L’ultima domanda da porsi, però, è di quale Partito Democratico si troverà alla guida il vincitore delle primarie, perché ci sono numerosi campanelli di allarme, che stanno suonando da tempo e tutti insieme.
Per cominciare, alle elezioni amministrative di giugno, il PD ha perso altre roccaforti storiche: i comuni di Pisa, Massa e Siena, tra tanti altri. Poi, nelle due manifestazioni pubbliche convocate da Maurizio Martina, la prima a fine maggio contro la dichiarazione di Luigi Di Maio sull’impeachment al Presidente della Repubblica, la seconda a settembre in Piazza del Popolo a Roma, la partecipazione non è stata certo oceanica. Infine, oltre alla delusione delle elezioni, dal 4 marzo ad oggi, il partito si è indebolito ulteriormente nei consensi, attestandosi al 16,7% registrato dall’ultima Supermedia di fine anno.
Insomma, dopo le nuove primarie (previste per il 3 marzo 2019) il nuovo segretario del PD dovrà chiudere i conti con un 2018 che ha segnato una svolta, in negativo, nella storia dei democrat italiani. E non sarà facile scuotere un partito che nel Paese sembra ormai confinato nei centri urbani.

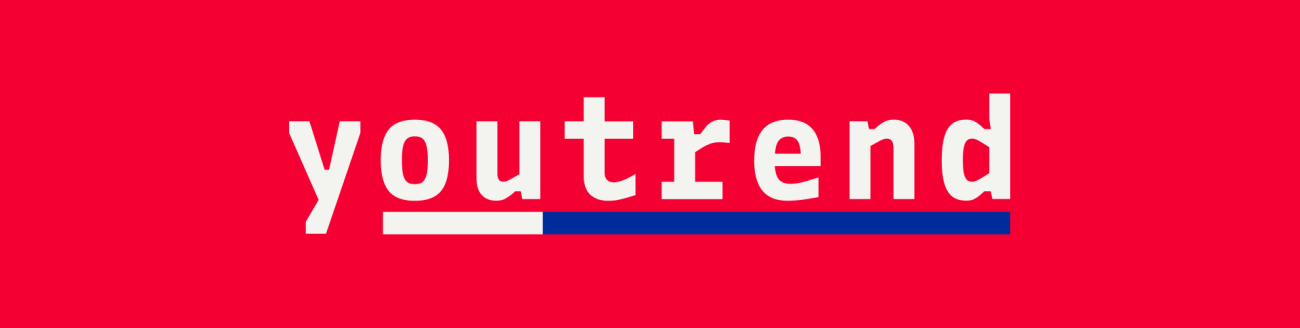
Commenta