Un Presidente dal curriculum tecnico impeccabile, che si rivela incapace di affrontare una crisi, sia economica che climatica. Oggi l’immaginario popolare lo ricorda come un incompetente, associandolo alla più grande sciagura in tempo di pace della storia americana. Si chiamava Herbert Hoover. E fino a quel 29 ottobre 1929 la sua immagine pubblica era davvero l’opposto: Hoover era l’icona stessa della success story americana, del self made man. Ma a partire dalla Grande Depressione, passando per la sconfitta alle elezioni presidenziali del 1932, il 31esimo Presidente degli Stati Uniti divenne, in parte immeritatamente, il simbolo del tecnocrate rimasto prigioniero della propria ideologia, incapace di vedere la realtà e agire in modo corretto per il bene del Paese.
Il suo avversario alle elezioni del 1932 si chiamava Franklin Delano Roosevelt, politico di carriera già rodato dall’esperienza senatoriale, già assistente segretario alla Marina nell’amministrazione Wilson e Governatore di New York, dove varò per la prima volta nella storia americana un ufficio per l’impiego statale, un assegno di disoccupazione e un vasto programma di lavori pubblici. Ma la campagna elettorale per le presidenziali fu molto più che un semplice scontro tra due politici di opposte fazioni.
Un mondo alla fine: dalla militanza alla personalizzazione della politica
Le elezioni del 1932 furono infatti rivoluzionarie per molti aspetti. Segnarono prima di tutto la fine del voto militante di appartenenza, che fino ad allora aveva retto gli equilibri della politica americana. Un sistema diviso per blocchi sociali con i propri giornali e le proprie “macchine” urbane di controllo clientelare del voto, ma che nelle elezioni del 1920 e del 1924 aveva mostrato segni di cedimento, portando l’affluenza a scendere sotto il 50%. La sostanziale corruzione di questo sistema venne gradualmente soppiantato dal voto d’opinione, dove a prevalere era invece la comunicazione centrata sempre più sulla figura del leader. Proprio nel 1932 si registrò una forte sterzata in questa direzione, con l’avvento dell’empatia come elemento caratteristico del candidato Presidente. Un’empatia che si traduceva nell’adozione di un tono più confidenziale nei discorsi politici.
Un cambiamento alimentato anche della fine della prosperità che aveva garantito benessere nel corso degli anni ’20, i cosiddetti Roaring Twenties. Nei primi anni del nuovo decennio si susseguono invece gli effetti del crollo della Borsa di Wall Street del 1929 e della Dust Bowl, ma anche emergenze climatiche come la siccità che colpì la regione agricola delle Grandi Pianure, e portò a una migrazione di massa dal Kansas, dall’Oklahoma e dall’Arkansas verso la California, oggetto dell’epopea raccontata da John Steinbeck nel suo romanzo corale Furore, che avrebbe dato origine alla cultura degli Okies.
Herbert Hoover: una storia di ascesa e di caduta
È il 3 marzo 1929. A Washington, di fronte al Campidoglio, Herbert Hoover giura come trentunesimo presidente degli Stati Uniti. L’ex segretario al commercio delle amministrazioni Harding e Coolidge è uno degli uomini più ammirati d’America, e ciò è ben individuabile nel percorso che lo porta alla Casa Bianca: nomination repubblicana ottenuta all’unanimità per acclamazione, 58,2% del voto popolare alle Presidenziali, 40 stati vinti e 444 grandi elettori. Hoover fa breccia anche nel Solido Sud ex confederato, dominato dalla corrente segregazionista del partito democratico, vincendo in Texas, Florida, Tennessee, North Carolina e in Virginia.
Il consenso di cui gode sembra blindato, legato al partito repubblicano che domina il cosiddetto terzo sistema dei partiti. Un presidente democratico non riesce a ottenere la maggioranza assoluta dal 1852 (Samuel Tilden, nel 1876, ottenne la maggioranza popolare, ma non seppe conquistare la maggioranza dei grandi elettori). E del resto è il terzo presidente repubblicano di fila: dal 1861, solamente Grover Cleveland, per due mandati non consecutivi, e Woodrow Wilson sono infatti riusciti nell’impresa di far entrare i democratici nella Sala Ovale. I democratici sembrano non volersi riprendere dai fantasmi della guerra civile, rimanendo legati ad un bacino elettorale sudista, mantenuto grazie anche a violenze quotidiane nei confronti della popolazione afroamericana.
La storia personale di Hoover contribuisce a intensificare il vantaggio repubblicano, e il candidato Presidente la cura quotidianamente, grazie ai suoi consulenti, giornalisti e uomini provenienti dal mondo dell’advertising. Hoover non è un grande oratore né tanto meno un trascinatore di folle (un saggio pubblicato nel 1973 dedicato al suo rapporto con i media lo descrive come un “introverso aggressivo“), ma piace molto perché è stato l’artefice della propria fortuna: figlio di una famiglia quacchera povera dell’Iowa, orfano all’età di dieci anni di entrambi i genitori, a tredici interrompe gli studi per lavorare come impiegato per la società immobiliare dello zio. Diventa geologo minerario nel 1895, dopo essere entrato a Stanford per un soffio. Avvia la carriera di consulente e manager di imprese minerarie e gira per il mondo, quindi ne diviene azionista, accumulando una grande ricchezza.
Le sue capacita lo aiutano a fare il grande salto nell’arena pubblica quando si trova a Londra nel luglio 1914. Era appena scoppiata la Grande Guerra: la prontezza di Hoover fu cruciale nell’organizzare il rimpatrio di 100 mila cittadini americani, rimasti bloccati in Europa. Qualche anno più tardi avrebbe dichiarato: “Quel 2 agosto la mia carriera finì. Entrai per sempre nella vita pubblica”. Perché a partire da allora, infatti, le sue capacità sarebbero state sfruttate dall’amministrazione Wilson per rifornire di cibo il Belgio tramite la Belgium Relief Commission.
Da quel momento la sua carriera nel settore pubblico non conosce soste: direttore della U.S. Food Administration durante la Guerra e Segretario al Commercio della nuova amministrazione Harding. Di fatto, Hoover diventa un Segretario di Stato ombra, che realizza accordi economici e commerciali con i paesi europei, latinoamericani e asiatici. Il merito della prosperità americana negli anni ’20 è largamente accreditato a lui, al Grande Ingegnere, un pragmatico moderato in grado di intervenire con la mano pubblica ove necessario e di favorire gli investimenti privati. Questo mix economico viene definito volontarismo. E sembra funzionare molto bene. Tanto che Hoover sembra l’uomo giusto al posto giusto per risolvere qualsiasi tipo di crisi, come dimostrò abilmente nella gestione dell’esondazione del Mississippi, nel 1927. Durante la campagna del 1928 uno dei suoi filmati lo descrive come il Master of Emergencies. Questa esaltazione delle proprie capacità, del proprio operato, unita ad alcune dichiarazioni improvvide come “un pollo per ogni pentola” e “inauguriamo un’era di prosperità senza precedenti”, si rivelerà essere un boomerang clamoroso.
Da Panico a Depressione: un “Nuovo Patto” per l’America
Hoover era stato uno dei più forti contestatori degli speculatori di Wall Street. Come segretario al commercio era stato un critico ardente della speculazione finanziaria e aveva ripetutamente chiesto al presidente Calvin Coolidge di varare una legge sull’insider trading.
Quando esplode la Grande Depressione, il Presidente fa però emergere il suo lato rigido: se da una parte comprende con difficoltà i propri errori, dall’altra è soprattutto incapace di empatizzare con il popolo, di essere quel comunicatore, quella guida, di cui il Paese necessitava per essere guidato fuori dalla crisi. D’altronde occorre sottolineare come fu probabilmente l’ultimo Presidente ad avere difficoltà a parlare in modo convincente davanti a un pubblico. Cerca sì di agire, ma lo fa con titubanza e poca efficacia.
Solo nel 1931, quando il paese è devastato dagli effetti combinati della siccità e della Depressione, Hoover si decide infatti a varare un piano di interventi pubblici straordinari, estremamente moderato per volume di investimento, ma che comunque pose le fondamenta per diverse delle azioni intraprese da Roosevelt negli anni del New Deal.
Ad aggravare la situazione contribuirono anche il deterioramento dei suoi rapporti con la stampa, nonostante un brillante inizio, e con il Congresso. I repubblicani stessi individuano infatti in Hoover un corpo totalmente estraneo alle dinamiche congressuali: quella alla Casa Bianca era infatti la sua prima esperienza politica.
Una serie di circostanze che fa sì che nel 1932 i democratici pregustino un ritorno al potere, questa volta con l’obiettivo di rimanerci a lungo. Il carismatico governatore Franklin Delano Roosevelt ha un background radicalmente opposto a quello di Hoover. Nasce in una famiglia ricca e influente dello stato di New York con radici anglo-olandesi. Nella sua infanzia e adolescenza ci sono stati viaggi in Europa e precettori privati in casa, coronati poi dall’ammissione ad Harvard senza particolari meriti personali.
Alla carriera da avvocato, però, preferisce la politica, ma a differenza del suo lontano cugino, il Presidente Teddy Roosevelt, sceglie il partito democratico. Senatore statale nel 1910 e sottosegretario alla Marina nel 1913, nel 1920 è candidato vicepresidente. Dopo essersi ripreso da un grave attacco di poliomielite, nel 1928 diventa governatore di New York. Da lì gestisce la crisi a livello statale, in ossequio alla teoria del volontarismo che demanda agli stati la maggior parte del lavoro. Roosevelt, come la sua controparte quattro anni prima, incontra pochi ostacoli. Molto popolare tra i lavoratori del Nord, compresi gli afroamericani, e non ostile ai segregazionisti del Sud, tanto da nominare uno di loro per la vice-presidenza, lo Speaker della Camera dei Rappresentanti John Nance Garner, proveniente dal Texas. La classe media impoverita che ha sostenuto con entusiasmo Hoover ora vede Roosevelt come la possibile salvezza, soprattutto dopo aver sentito il discorso – il primo nella storia delle convention democratiche – nel quale il candidato Presidente accetta la nomina e cita, per la prima volta, la necessità di un New Deal per il bene dei cittadini americani.
On the farms, in the large metropolitan areas, in the smaller cities and in the villages, millions of our citizens cherish the hope that their old standards of living and of thought have not gone forever. Those millions cannot and shall not hope in vain.
I pledge you, I pledge myself, to a new deal for the American people. Let us all here assembled constitute ourselves prophets of a new order of competence and of courage. This is more than a political campaign; it is a call to arms. Give me your help, not to win votes alone, but to win in this crusade to restore America to its own people. – Franklin Delano Roosevelt, Democratic National Convention, 1932
Hoover “l’assassino di bambini” e Roosevelt “il bolscevico”
La campagna elettorale, però, si rivela più cruda del solito. In particolare, si spreca il ricorso a quelle che oggi definiremmo come fake news: il Presidente Hoover, costretto a una campagna complessa, spesso fischiato e oggetto di lanci di pomodori, accusa Roosevelt di essere l’avvelenatore della politica americana, il portatore di una filosofia di governo “direttamente proveniente dal pentolone delle streghe che sta bollendo in Russia”.
In realtà, però, è Hoover ad essere il principale bersaglio delle falsità. Negli ultimi anni di presidenza, parallelamente alla sua incerta azione nei confronti della crisi, le fake news a suo carico divennero sempre più numerose: Hoover si era arricchito sulle spalle dei belgi, era odiato istintivamente dai cani, era complice nel rapimento del figlio dell’aviatore Charles Lindbergh e un agente del governo britannico, come sosteneva il pamphlet The Strange Career of Mr. Hoover under two flags, scritto da John Hamill, un diffamatore professionista di origini britanniche.
Un episodio in particolare lo condannò agli occhi dell’opinione pubblica: il 28 luglio 1932, 43mila veterani insieme con le loro famiglie marciarono su Washington per chiedere un anticipo della loro buonuscita. Si accamparono vicino al Campidoglio e vennero dispersi da un contingente di mille soldati. L’accampamento venne dato alle fiamme. Due morti vennero causati dalla polizia locale. Ma nelle cronache, il nome di Hoover risultò quello del massacratore di veterani, del “gasatore di bambini” e di colui il quale “aveva ordinato di uccidere un bambino”. Tutte esagerazioni giornalistiche del reporter di The Nation Paul Y. Anderson, che giocarono a favore di Roosevelt. La sua fama era oramai del tutto compromessa: le baraccopoli venivano chiamate Hooverville e i giornali con cui si coprivano i senzatetto le Hoover blankets.
Hoover conosceva molto bene il potere delle pubbliche relazioni, tanto da mediatizzare molto il dipartimento del commercio mentre era in carica, grazie anche alla consulenza informale di uomini come il direttore del Buffalo Evening News Alfred Kirchhofer. Lo stesso Kirchhofer, però, nel luglio 1930 scriveva al presidente un giudizio tranchant: “L’opinione pubblica, senza guardare l’affiliazione partitica, definisce la sua amministrazione fino ad oggi come un fallimento”.
Diverse personalità per nuovi media
Il motivo principale della discrepanza esistente tra il popolare segretario al Commercio e l’odiato presidente è presto spiegato: l’uso dei media per Hoover era di tipo manageriale e primo novecentesco. Promuoveva la sua immagine in astratto come summa di esperienza, competenze e successi dimostrabili sul campo, anche quando usava la radio o il cinema. La sua figura era grigia e poco carismatica, la sua espressione facciale ricordava quella di un “bambino imbronciato” e il tono della voce era metallico e monocorde (come si può verificare facilmente qui). Tutto ciò nonostante fosse stato un’entusiasta del mezzo radiofonico e, da segretario al Commercio, regolò l’assegnazione delle frequenze agli operatori privati.
Al contrario, Roosevelt aveva sperimentato la radio in modo diverso: come rafforzamento della sua leadership personale nella veste di governatore di New York. Dovendo fronteggiare una legislatura a maggioranza repubblicana e quotidiani sostanzialmente ostili al suo programma decise, su consiglio del suo consulente Stephen Early, futuro press secretary alla Casa Bianca, di lanciare un programma radiofonico sulla stazione WGY per rivolgersi direttamente agli elettori, affinché facessero pressione sui loro rappresentanti per convincerli della bontà dei provvedimenti. Per Roosevelt non fu quindi difficile, durante la campagna elettorale, rivolgersi direttamente al pubblico ed empatizzare con esso. Hoover avrebbe invece preferito una campagna più tradizionale, fredda, distaccata, affidata ai suoi alleati sul territorio.
Questa differenza si nota anche nei manifesti della campagna elettorale. Per quanto i tempi siano ancora caratterizzati evidentemente da un approccio fortemente influenzato dal passato, la comunicazione di Hoover appare più assertiva, fredda e distaccata, così come l’immagine del Presidente, che sembra quasi osservare l’elettore con rigorosa severità.
Per quanto non si possa certo paragonare a ciò che osserveremo nei decenni successivi, è evidente la differenza con la strategia democratica. Nel primo manifesto l’immagine di Roosevelt sembra più rilassata, ma soprattutto è accompagnata da un messaggio elettorale più profondo di quello evidenziato dai repubblicani, che rende nel complesso l’impatto visivo meno distaccato e pedante. Ancora più netta è la differenza con la seconda immagine, riferita a un’inserzione giornalistica. In particolare, è interessante notare come la maggior parte del contenuto ruoti intorno ai bisogni del popolo, ricorrendo al tema già citato di empatizzare con esso: il candidato presidente trasmette il messaggio di essere ben consapevole della sofferenza di chi ha perso il proprio lavoro, di chi soffre la fame o di chi ha dovuto chiudere la propria impresa per colpa dell’incompetenza del Presidente Hoover nell’affrontare la crisi.
Gli slogan, infine, mostravano un’efficacia antitetica: “Happy days are here again” trasmetteva un messaggio di speranza tanto necessario agli americani. Lo slogan era ispirato a una canzone tratta da un musical ambientato nel primo dopoguerra, Chasing Rainbows (1930), che venne adottata anche come jingle non ufficiale della campagna di Roosevelt. Quello scelto da Hoover, cioè “Prosperity is just around the corner” risultava invece beffardo e indisponente, tanto da venire spernacchiato anche in un musical del 1976, Annie, ambientato proprio negli anni della Grande Depressione.
Anche se nessun sondaggio diede mai per valida la possibilità che il presidente potesse essere rieletto, il risultato ebbe conseguenze importanti negli anni a venire. La coalizione tra minoranze etniche del Nord, segregazionisti e classe media, sarebbe divenuta l’architrave del dominio democratico nella politica americana fino al 1968, quando la vittoria di Richard Nixon alle presidenziali scosse alle fondamenta quell’impianto politico: un patchwork di interessi contrapposti, ma uniti dall’uso della spesa pubblica per alleviare le sofferenze della popolazione, rilanciare l’economia e costruire un nuovo welfare state.
L’8 novembre 1932 la vittoria di Franklin Delano Roosevelt fu schiacciante. Il democratico raccolse il 57,4% dei voti, contro il 39,7% di Hoover, conquistando 472 grandi elettori.
Hoover si ritirò dalla politica attiva (ritentò la corsa presidenziale nel 1936 e nel 1940, con poco successo) e negli ultimi anni sono usciti studi che apprezzano maggiormente gli sforzi sinceri che attuò per superare l’ortodossia liberista dell’epoca. Ma fu anche lui, in opere come Freedom Betrayed, una critica dura del New Deal scritta nel 1944 ma pubblicata solo nel 2012, a cementare la sua immagine come stolido difensore della libertà di mercato. In realtà Hoover avrebbe voluto una radicale innovazione manageriale del ruolo del presidente, simile a quella attuata da Roosevelt e dai suoi successori. Una prova di tale affermazione, e della forse eccessiva severità di giudizio verso Hoover da parte della storia, si riscontra nelle parole di uno dei principali consiglieri del Presidente Roosevelt, Rexford G. Tugwell:
“Quando tutto ebbe fine, una volta scrissi una lista delle iniziative del New Deal che erano state inaugurate durante gli anni in cui Hoover fu Segretario al Commercio e Presidente. Dovetti concludere che le sue politiche erano sostanzialmente corrette, il New Deal dovette molto a ciò che Hoover aveva iniziato […] Hoover voleva – e lo aveva detto in modo chiaro – quasi tutti i cambiamenti che sono stati portati sotto l’etichetta del New Deal”.
—————————————————————————–
Bibliografia essenziale:
- William E. Leuchtenburg, Herbert Hoover, Times Books, 2009
- Kenneth Whyte, Herbert Hoover: a Extraordinary Life in Extraordinary Times, Vintage, 2017
- Clark Lloyd, Aggressive Introvert: Herbert Hoover and Public Relations Management, Ohio State University Press, 1973
- James N. Gregory, American Exodus: The Dust Bowl Migration and Okie Culture in California, Oxford University Press, 1989
- Roy Jenkins, Franklin Delano Roosevelt, Times Books, 2003
- H.W. Brands, Traitor to His Class: The Privileged Life and Radical Presidency of Franklin Delano Roosevelt, Ancor 2008
- Kathleen Jamieson Hall, Packaging the Presidency, Oxford University Press, 1996
- Michael McGerr, The Decline of Popular Politics, Oxford University Press, 1984
- David Greenberg, Republic of Spin: An Inside History of the American Presidency, W.W. Norton, 2016
- Tutte le citazioni dei discorsi pubblici dei presidenti si trovano invece nel database The American Presidency Project, dell’università di Santa Barbara: https://www.presidency.ucsb.edu/

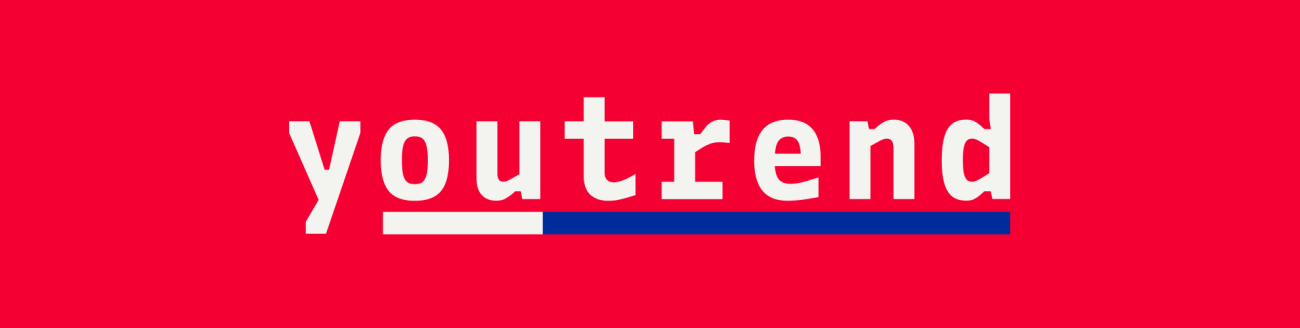
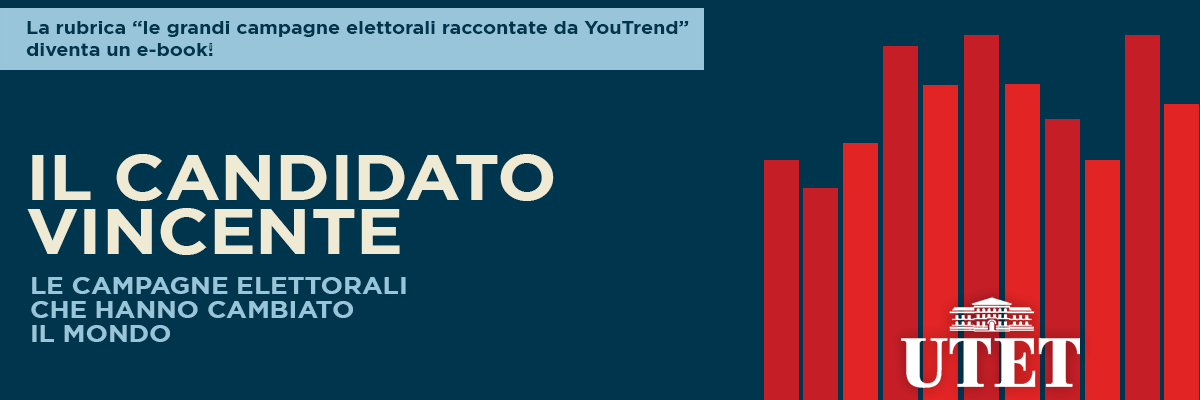
Commenta